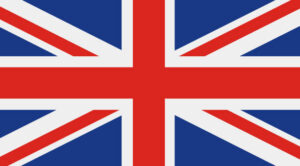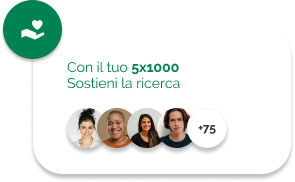Nei protocolli terapeutici per la fibrosi cistica la somministrazione di azitromicina continuativa a basso dosaggio nei pazienti di età superiore ai 6 anni e portatori cronici di Pseudomonas aeruginosa (P.a.) nelle vie aeree, occupa un posto ad oggi raramente messo in discussione. Azitromicina è un antibiotico che viene usato come antinfiammatorio: i risultati di trials clinici controllati ne hanno dimostrato l’efficacia nel diminuire l’esagerata risposta infiammatoria caratteristica della malattia e il conseguente impatto positivo sull’evoluzione della broncopneumopatia.
Fino ad ora, però, nessuno studio ha potuto considerare un numero di pazienti sufficientemente elevato, un tempo sufficientemente lungo di osservazione e, soprattutto, l’effetto del farmaco nell’ambito del follow-up usuale del paziente, diverso da quello richiesto nel corso di un trial clinico controllato. Dubbi possono essere ancora presenti, quindi, sull’entità dell’impatto di questa terapia in quella che gli anglosassoni definiscono la real life (vita reale). Gli studi che indagano l’efficacia di un farmaco dopo che è stato messo in commercio e viene assunto dai malati nella vita reale si chiamano anche studi-post-marketing. Gli autori di questo studio (Clinici e Ricercatori di Centri FC francesi e Ricercatori che lavorano nell’ambito del Registro Francese FC) hanno analizzato i dati raccolti nel Registro di malattia, al fine di ovviare ai problemi connessi ai precedenti studi, grazie alle potenzialità, anche in senso numerico, di questo irrinunciabile strumento di ricerca (1).
Sono entrati nello studio 1065 bambini (gruppo A) e 990 adulti (gruppo B), portatori cronici di P.a. che avevano assunto azitromicina nel periodo 2001-2011. Sono stati raccolti i dati relativi a 2 anni prima e fino a 5 anni dopo l’inizio del trattamento. Per tutti i pazienti considerati sono stati raccolti dati riferiti al sesso, all’età di inizio del trattamento, ai risultati del test di funzionalità respiratoria (FEV1%), al numero di riacutizzazioni della broncopneumopatia (valutato in base al numero di cicli di antibiotici e.v. effettuati).
Questi i risultati: non c’era differenza nei due gruppi riguardo al sesso. L’età media di inizio del trattamento è stata di 12 anni nel gruppo A e 23 anni nel gruppo B. All’inizio del trattamento FEV1% medio era pari a 77% nel gruppo A (bambini) e 60% nel gruppo B (adulti). In entrambi i gruppi, FEV1% era migliorato significativamente (in media 1,6% e 1,3% rispettivamente) nel primo anno di trattamento, e il suo declino negli anni successivi era risultato inferiore rispetto al declino annuo che si era verificato negli anni prima dell’inizio della terapia. Nel gruppo A il numero delle riacutizzazioni broncopolmonari è rimasto inalterato rispetto agli anni pre-azitromicina nel primo anno di terapia, per poi diminuire significativamente. Nel gruppo B il numero di riacutizzazioni ha dimostrato la medesima tendenza, anche se la diminuzione di riacutizzazioni negli anni post-trattamento non ha raggiunto un valore statisticamente significativo.
Abbiamo segnalato questo lavoro perché, come gli autori stessi sottolineano, dimostra in modo autorevole che azitromicina, pur non dimostrando effetti positivi clamorosi, è una terapia utile, con effetti immediati sulla funzionalità respiratoria e, più ritardati, sulla riduzione delle esacerbazioni broncopolmonari. Questo studio, però, assume ancora più interesse, perché risponde, tra i primi, a una esigenza molto sentita di revisione degli schemi terapeutici in uso, anche alla luce delle più attuali prospettive terapeutiche offerte dai modulatori della CFTR. Grazie all’utilizzo di strumenti di lavoro come i Registri di patologia o la raccolta dati mirata a uno specifico intervento terapeutico, sarà infatti necessario mettere in atto studi su grandi numeri e con lungo periodo di follow-up, che, raccogliendo dati osservazionali retrospettivi, ma anche prospettici con gruppo di controllo, permetteranno di far luce su cosa sia veramente utile al paziente, senza un inutile aggravio di tempo e energie dedicati alle cure quotidiane.
1) Denis A, Touzet S, Diabaté L, Durieu I, Lemonnier L, Poupon-Bourdy S, Iwaz J, Reynaud Q, Rabilloud M Quantifying Long-term Changes in Lung Function and Exacerbations after Initiation of Azithromycin in Cystic Fibrosis. Ann Am Thorac Soc. 2019 Oct 11. doi: 10.1513/AnnalsATS.201812-882OC.