
La fibrosi cistica (in passato nota come mucoviscidosi) è una malattia genetica rara generalmente grave, presente fin dalla nascita, causata da un’alterazione genetica (mutazione) del gene CFTR. Questo gene, il cui nome completo è Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, codifica una proteina che si trova nelle membrane cellulari di diversi epiteli e che regola il passaggio di ioni, come il cloruro e il bicarbonato.
Ogni individuo possiede due copie del gene CFTR, una ereditata dal padre e una dalla madre. La malattia si manifesta quando entrambe le copie sono mutate, ereditate da genitori che, nella maggior parte dei casi, sono portatori sani di una copia del gene senza esserne consapevoli. In Italia, si stima che ci sia un portatore sano ogni 30 persone circa. Una coppia di portatori sani ha, per ogni gravidanza, una probabilità su quattro di avere un figlio affetto da fibrosi cistica, cioè con due copie mutate del gene CFTR.

La fibrosi cistica compromette le secrezioni di molti organi, rendendole più dense, disidratate e meno fluide, contribuendo così al loro danneggiamento. Gli organi maggiormente colpiti sono bronchi e polmoni, dove il muco tende a ristagnare, causando infezioni e infiammazioni progressivamente più gravi. Questi processi, nel tempo, possono portare a insufficienza respiratoria.
Oltre ai disturbi respiratori, i sintomi interessano anche il pancreas, che perde la capacità di riversare nell’intestino gli enzimi necessari per la digestione. Questo provoca diarrea, malassorbimento, ritardo della crescita nei bambini e uno scarso stato nutrizionale negli adulti. Il progressivo danneggiamento del pancreas può portare, con l’età, allo sviluppo di una forma di diabete. Altre manifestazioni possono coinvolgere intestino, fegato, cavità nasali e, nei maschi, i dotti deferenti. Anche le ghiandole sudoripare risultano compromesse, producendo un sudore estremamente salato, caratteristica che rende il test del sudore un elemento chiave per la diagnosi.
La sintomatologia può variare significativamente da persona a persona, in funzione di fattori genetici e ambientali.
Fino a circa una decina di anni fa, le cure per la fibrosi cistica erano rivolte esclusivamente alla gestione dei sintomi e alla prevenzione delle complicanze. Protocolli terapeutici condivisi a livello internazionale, applicati nei centri specializzati, vengono personalizzati in base all’età e ai sintomi di ciascun paziente. In linea generale, il trattamento prevede l’uso di antibiotici per le infezioni polmonari, aerosol con antibiotici e farmaci fluidificanti, fisioterapia respiratoria, enzimi digestivi, una nutrizione ipercalorica e la gestione delle complicanze. Nei casi di insufficienza respiratoria irreversibile, il trapianto polmonare rappresenta una possibile opzione terapeutica.
Negli ultimi anni, sono stati introdotti nuovi farmaci mirati a correggere la proteina CFTR alterata, agendo in maniera specifica a seconda delle mutazioni del gene. Questi farmaci, detti modulatori della proteina CFTR, sono molecole in grado di correggere parzialmente il malfunzionamento della proteina, con effetti variabili in base alle mutazioni genetiche presenti. Alcuni di essi si sono dimostrati particolarmente efficaci, contribuendo a una riduzione significativa dei sintomi e a un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Grazie a questi progressi, si sta assistendo a un ulteriore aumento delle aspettative di vita per le persone affette da fibrosi cistica.

Circa un italiano su 30 è portatore sano di fibrosi cistica. Questo significa che approssimativamente una coppia su 900 è composta da due portatori sani del gene CFTR mutato, con una probabilità del 25% per ogni gravidanza di avere un bambino affetto da fibrosi cistica.
Oggi, grazie ai progressi della genetica, è possibile identificare i portatori sani attraverso il test genetico del portatore, che viene eseguito in laboratori specializzati in tecniche di genetica molecolare. Questo test può essere effettuato su presentazione di una richiesta del medico curante, offrendo alle coppie informazioni fondamentali per pianificare il proprio futuro familiare.
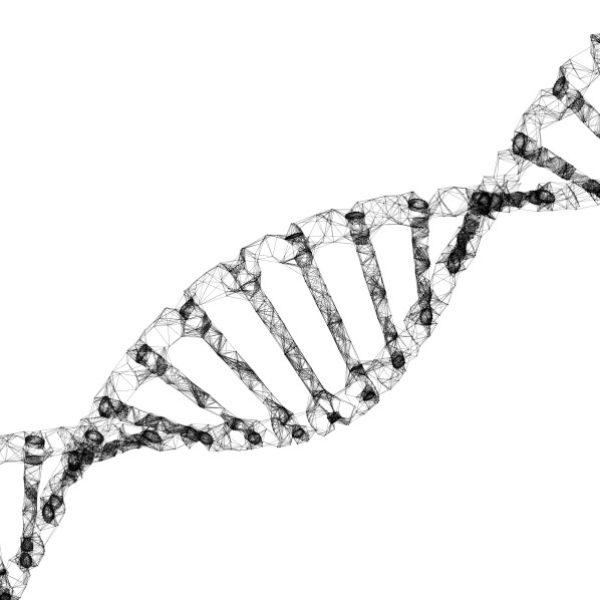
La fibrosi cistica è una malattia complessa, caratterizzata da una notevole variabilità nella severità e nel tipo di sintomi da persona a persona. Diversi fattori, come l’età alla diagnosi e il tipo di mutazioni del gene CFTR, possono influenzarne sia l’andamento che l’evoluzione.
Grazie alla ricerca scientifica, all’organizzazione delle cure e al continuo miglioramento delle terapie, si sono compiuti progressi significativi. Rispetto agli anni ’50, quando un bambino affetto da questa malattia difficilmente raggiungeva l’età scolare, oggi la prospettiva di vita e la qualità della vita dei pazienti sono notevolmente migliorate, testimoniando l’importanza dell’innovazione medica e della gestione specializzata.
Oggi, grazie ai progressi terapeutici, ci sono più adulti che bambini affetti da fibrosi cistica. Molti di loro studiano, lavorano e costruiscono una famiglia. Le statistiche indicano un’aspettativa mediana di vita ormai ben superiore ai 40 anni, un risultato reso possibile dai modulatori della proteina CFTR.
Tuttavia, non tutte le persone con fibrosi cistica possono beneficiare di questi farmaci. In Italia, circa il 30% dei pazienti presenta mutazioni del gene che impediscono la produzione della proteina CFTR o ne consentono la produzione in quantità estremamente ridotte. Per queste mutazioni, attualmente, non esistono modulatori disponibili. La ricerca scientifica è fortemente concentrata sull’identificazione di soluzioni per queste forme e, soprattutto, sulla possibilità di correggere completamente il difetto della proteina CFTR.
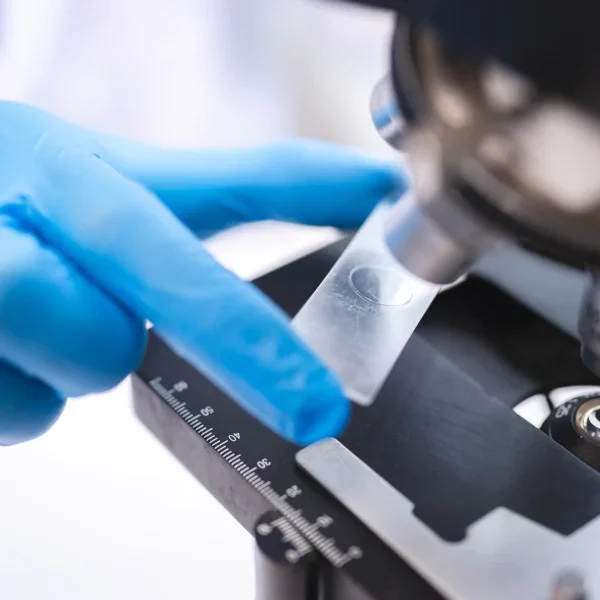
Scaricabili gratuitamente, una selezione di materiali informativi, divulgativi e di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica (mucoviscidosi) è disponibile per tutti. Questi materiali includono i fondamentali per comprendere la malattia, affrontarne la prevenzione e gestire le cure in modo pratico durante infanzia, adolescenza e età adulta.
È possibile richiedere copie stampate di ciascuna delle pubblicazioni, tra cui Fibrosi cistica: parliamone insieme, scrivendo a fondazione.ricercafc@aovr.veneto.it.
Le copie saranno inviate addebitando esclusivamente le spese postali.
TEST PER IL PORTATORE SANO DI FIBROSI CISTICA
IL TEST DEL SUDORE PER LA DIAGNOSI DI FIBROSI CISTICA
Stato regolatorio per i farmaci modulatori di CFTR attualmente in commercio
Mutazioni CFTR con funzione minima
Suggerimenti per il ritorno a scuola e al lavoro in relazione alla pandemia Covid-19
Fibrosi cistica: parliamone insieme. L’infanzia
Fibrosi cistica: parliamone insieme. L’adolescenza
Significato della brevettazione di una invenzione, fra ricerca e mercato
Vent’anni di attività della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica
Il trapianto polmonare in fibrosi cistica
Fibrosi cistica, conoscere la malattia genetica grave più diffusa
Nutrizione enterale con PEG in età pediatrica
Linee guida per la prevenzione di infezioni in fibrosi cistica
Linee guida per il trattamento dei bambini in età prescolare affetti da fibrosi cistica
Nutrizione in fibrosi cistica: linee guida
Legge 87/1999 su diritti del lavoro disabili (1999)
Circolare attuativa Legge 548/93 sulla Fibrosi cistica (1994)
Circolare ministeriale su finanziamento ricerca FC Legge 548/93 (2000)
Legge 548/93 – Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica
Il trial clinico: cos’è e come si fa
Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
Fertilizzazione in vitro e diagnosi genetica preimpianto
Gli studi clinici
lo spot istituzionale