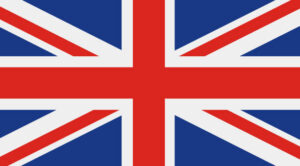Ci sembra opportuno impostare questa risposta puntando l’attenzione, nella prima parte, su due informazioni di ordine generale e poi, nella seconda, esponendo alcune riflessioni che possono essere utili nella relazione con una persona con malattia FC.
Attesa mediana di vita. Secondo i dati più recenti del Registro canadese, l’attesa mediana di vita per un bambino che nasce oggi con la fibrosi cistica è intorno ai 50 anni, secondo quello degli Stati Uniti intorno ai 48 anni (1). Sempre negli Stati Uniti, negli anni ‘90, era intorno ai 30 anni e questo dice quali progressi siano stati fatti nei decenni recenti. Negli ultimi anni, al prolungamento della vita ha contribuito anche la disponibilità di farmaci che per la prima volta intervengono sul difetto che sta alla base della malattia, come pure l’incremento dei trapianti polmonari e il miglioramento del loro trattamento.
Ricordiamo che l’attesa mediana di vita è una predizione statistica di qual è l’età alla quale sopravvive il 50% di una popolazione sufficientemente ampia di malati, ottenuta con osservazione di lungo periodo, registrando anno per anno (incluse le nuove diagnosi) quanti sono viventi e quanti vengono a mancare in quell’anno (
Survival curves e Life tables). Perciò il registro canadese, che ebbe inizio nel 1970, può elaborare correttamente le curve di sopravvivenza e fornire il dato dell’attesa mediana di vita. Non può farlo ancora il Registro italiano che raccoglie le informazioni concernenti i malati italiani da un periodo più breve, ovvero dal 1988 (2). Questa è la ragione per cui non sappiamo precisamente quale sia l’attesa mediana di vita dei pazienti italiani, ma abbiamo ragioni per pensare che in Italia l’aspettativa di vita non si discosti sostanzialmente da quella dei malati canadesi o statunitensi (1, 2).
Inoltre, sottolineiamo che queste previsioni non tengono assolutamente conto dei rilevantissimi progressi che i nuovi farmaci, anche chiamati “farmaci modifica-malattia”, produrranno sull’attesa di vita, in particolare della popolazione che oggi è adulta. Per questi pazienti sarebbe più corretto usare fin d’ora una diversa e più ottimistica proiezione statistica chiamata attesa di vita condizionata, vale a dire influenzata anche dal progresso delle cure (3).
Per concludere, vale la pena ribadire che queste indicazioni statistiche servono solo per una valutazione generale sull’andamento di una popolazione con FC, ma non possono predire nella singola persona quale possa essere realmente la sua aspettativa di vita. La malattia può essere estremamente variabile come gravità e decorso e solo i medici del centro che hanno in cura quella persona possono darle le informazioni più accurate.
Possibilità che una donna con fibrosi cistica abbia figli e rischio che i figli abbiano la fibrosi cistica. La donna con FC, nella maggioranza dei casi, può avere figli in modo naturale e sono oggi sempre più numerose le gravidanze da parte di donne affette da FC, soprattutto se con malattia stabile e buone o discrete condizioni respiratorie e di nutrizione. Solo in una quota ridotta di donne con FC c’è una condizione di ipofertilità, che può rendere più difficile il verificarsi di una gravidanza attraverso il rapporto sessuale. Nelle donne con FC in buone condizioni di salute, la gravidanza non costituisce un fattore di peggioramento della malattia, sempre che sia ben assistita e segua i programmi del centro di cura. Nella fase della progettazione della gravidanza, è opportuno che la donna interpelli i medici del centro, perché facciano una valutazione delle sue condizioni cliniche e, più in generale, dell’andamento della malattia nel tempo.
Per quel che riguarda il nascituro, la genetica assicura che i figli saranno sani se il partner non è portatore FC. Da un punto di vista pratico, occorrerà quindi che, nel momento in cui si progetta una gravidanza, il partner faccia il test del portatore: la probabilità che il figlio di una donna con FC nasca affetto, è bassissima se il partner ha fatto il test ed è risultato non portatore. Si raccomanda però un test genetico approfondito con indagine di ampio numero di mutazioni del gene CFTR (test genetico di secondo livello). Con le tecniche oggi disponibili la possibilità che qualche mutazione rara sfugga alla ricerca nel partner è veramente molto bassa, per cui il rischio di figlio malato per la coppia formata da una donna affetta e un partner negativo si può stimare intorno a 1 su 500 (equivalente allo 0,2%).
Si deve tenere a mente, tuttavia, che non la malattia ma lo stato di portatore verrà comunque trasmesso, perché il malato ha due copie di mutazioni del gene CFTR e ne trasmette sempre una. Quindi il nuovo nato sicuramente sarà un portatore sano FC.
Se il partner invece risultasse portatore sano al test, il rischio di avere un figlio malato è elevato: 1 su 2 (equivalente al 50% di probabilità). In questo caso è possibile eseguire la diagnosi prenatale entro la decima settimana di gravidanza, per sapere se il nascituro è malato o semplicemente portatore sano.
Come affrontare la comunicazione sulla malattia FC nella relazione con una persona malata. Una persona maggiorenne che ha un problema di salute deve essere direttamente informata dal medico che la assiste. Una volta in possesso delle informazioni dovute, è lei sola che ha il diritto di tenerle per sé o condividerle con altri (genitori, familiari, amici, partner/ fidanzato/ marito). Alcuni malati decidono fin da subito di condividere quello che sanno, altri non lo fanno proprio, finché possono, altri lo fanno in parte e molto gradualmente.
L’aiuto che il partner può fornire è quello di cercare di capire le ragioni di un comportamento rispetto a un altro. Questo può essere fatto solo avendo il coraggio di parlare della questione direttamente con la persona malata. E la persona malata avrà molti modi per far capire com’è orientata, quali sono le difficoltà e quali le risorse disponibili. Il partner non può invadere l’autonomia della scelta, però quanto più mostrerà di non aver paura dell’argomento, e farà capire di considerare la fibrosi cistica una malattia vivibile, tanto più potrà avvicinare anche il malato a considerarla tale. Gli studi svolti in questo campo (4, 5), come pure l’esperienza clinica di chi scrive, suggeriscono come vantaggiosa la comunicazione diretta e non evitante gli aspetti più difficili. Un clima comunicativo, improntato alla franchezza e alla verità può aiutare il malato a sviluppare quelle risorse personali - definite con una parola: resilienza - che gli permettono di meglio adattarsi alla malattia. Un buon adattamento può favorire migliori relazioni sociali, maggior inserimento in varie attività e anche maggiore aderenza alle cure.
1) Aspettativa di vita delle persone con FC: un messaggio tabù o un dato di realtà in continuo miglioramento con cui confrontarsi positivamente?, 06/10/2016
2) Aspettativa di vita delle persone con FC: un aggiornamento, 07/02/2018
3) Mayer-Hamblett N, Polineni D, Heltshe SL . “In statistics we trust: Towards the careful derivation and interpretation of meaningful survival estimates in cystic fibrosis.” J Cyst Fibros. 2018 Jan 25.
4) Mitmansgruber H, Smrekar U, Rabaner B, Beck T, Eder J, Ellemunter H “Psychological resilience and intolerance of uncertainty in coping with cystic fibrosis”. J Cyst Fibros. 2016 Sep; 15(5):689-95. doi: 10.1016/j.jcf.2015.11.011. Epub 2015 Dec 10.
5) Borschuk AP, Everhart RS, Eakin MN, Rand-Giovannetti D, Borrelli B, Riekert KA. “Disease disclosure in individuals with cystic fibrosis: Association with psychosocial and health outcomes”. J Cyst Fibros. 2016 Sep; 15(5):696-702. doi: 10.1016/j.jcf.2016.02.011. Epub 2016 Mar 17.PMID: 26996270.