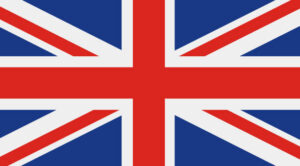Stare vicini a una persona con una malattia cronica, sottoposta a un trapianto, è certamente meritorio. La vicinanza si riempie di
significati positivi per entrambe le persone anche indipendentemente dalle aspettative di vita: ciò è reale perché per un singolo soggetto la medicina non riesce a fare una
previsione precisa. Provo a spiegarmi.
I registri internazionali riportano la
sopravvivenza dopo trapianto in un gruppo di circa 9.000 persone con fibrosi cistica sottoposte a trapianto polmonare nel periodo compreso tra il gennaio 1990 e giugno 2016. I risultati degli esiti dopo trapianto sono così descritti per questo grande gruppo di persone: la
mediana della sopravvivenza è di 9,5 anni, cioè il 50% delle 9.000 persone sopravvive di più di 9,5 anni; il 50% dello stesso gruppo meno di 9,5 anni. Questa è la descrizione “statistica”: mediamente, per l’insieme delle 9.000 persone la sopravvivenza è di quasi 10 anni e si tratta certamente di un buon risultato che è andato migliorando nel tempo, ma non sappiamo se un determinato soggetto cade nella metà che sopravvive di meno o nella metà che sopravvive di più di 10 anni. Chiedo al nostro interlocutore: serve proprio questa informazione?
Le cellule dei polmoni trapiantati
non hanno il difetto genetico della malattia. Occorre però considerare che possono intervenire sull’organo trapiantato delle
complicanze che non hanno a che fare con la fibrosi cistica, come il rigetto acuto o cronico. Le
infezioni dei polmoni da parte anche di microorganismi che non rappresentano un problema per le persone sane sono facilitate dalla
terapia immunosoppressiva e possono danneggiare i polmoni. Inoltre, la terapia immunosoppressiva può portare a complicanze come la perdita di funzione renale o a patologia tumorale.
C’è bisogno perciò di una
terapia continuativa e di controlli che, con diversa frequenza e in dipendenza dall’andamento, devono assicurarsi dello stato di salute del polmone e delle altre complicanze della fibrosi cistica, che riguardano organi diversi dai polmoni.