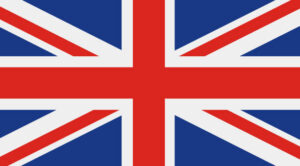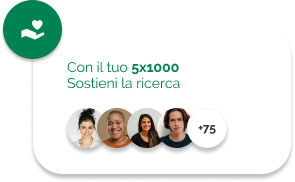Il gene della fibrosi cistica è stato identificato vent’anni fa. Subito dopo la sua scoperta si cominciò a parlare di un progetto molto ambizioso: mettere a punto una terapia genica, trasferire cioè una copia di gene normale alle cellule del polmone del malato. Il primo trial clinico fu realizzato in pazienti FC nel 1993 e fino ad oggi sono stati portati a termine 25 trials che hanno coinvolto complessivamente 450 pazienti (1). Tranne rare eccezioni, sono stati trial di fase I e II, quindi mirati a verificare la sicurezza della terapia. Nei rari casi in cui ci si è proposti di studiarne l’efficacia, questa è stata valutata attraverso saggi molecolari (misura del RNA messaggero della proteina CFTR) e/o funzionali (misura del trasporto del cloro). Queste prove hanno indicato in alcuni, ma non in tutti gli studi, che si può ottenere il trasferimento del gene normale e una parziale correzione (fino al 20%) del trasporto del cloro. Soprattutto nell’ultimo decennio è apparso sempre più evidente che trasferire il gene CFTR nel polmone è più difficile di quanto si era immaginato. In questa rassegna (1) i ricercatori, che fanno parte di uno dei più importanti consorzi di ricerca sulla terapia genica (United Kingdom Cystic Fibrosis Gene Therapy Consortium), discutono i problemi incontrati e i risultati finora ottenuti.
Il maggior ostacolo è che il polmone è solo apparentemente un organo di facile accesso: in realtà, proprio la sua capacità di sviluppare barriere efficienti contro l’ingresso di particelle estranee è quella che limita il trasferimento del gene. Le barriere sono di tipo fisico (il muco) e di tipo immunitario. Entrambe si oppongono all’insediamento stabile degli agenti che trasportano il gene normale all’interno delle cellule dei bronchi. E’ possibile che proprio i bambini piccoli che non hanno ancora sviluppato una malattia polmonare cronica con abbondante produzione di muco, siano i candidati più adatti per i trial di terapia genica futuri; come pure è possibile che questi trial debbano tener conto dell’uso efficace dei nuovi mucolitici (DNase)e in generale di una maggiore possibilità di controllare l’infiammazione/infezione respiratoria FC.
Sono stati sperimentati vari tipi di vettori del gene CFTR: i più usati sono stati i virus, soprattutto della famiglia degli Adenovirus. Il virus ideale è quello che è capace di incorporarsi stabilmente nel DNA della cellula polmonare trasmettendole il gene CFTR normale che trasporta; nello stesso tempo deve essere innocuo (non provocare infezione respiratoria) e non essere neutralizzato dal sistema immunitario. Ognuno di questi requisiti presenta specifici problemi non ancora superati. Ancora qualche difficoltà esiste e anche nella migrazione del vettore verso l’interno del nucleo della cellula e nell’ottenere la stabilità del gene CFTR nel tempo, una volta ottenuta la penetrazione all’interno delle cellule.
Di recente i virus chiamati Lentivirus si sono dimostrati i più adatti per una integrazione stabile con il genoma della cellula che “transfettano”. Ma sono oggetto di studio anche i vettori non-virali, fatti di particolari particelle naturali (nanoparticelle di DNA o lipidi). In particolare, nella sperimentazione di queste sono impegnate due grandi aziende farmaceutiche, la Copernicus Therapeutics, in parte supportata della CF Foundation americana, e il CF Gene Therapy Consortium, supportato dal CF Trust inglese.
Un campo vastissimo e promettente, anche se ancora piuttosto vago quanto ad evidenze, è quello che prevede la terapia genica combinata con l’utilizzo delle cellule staminali. E’ possibile trasferire, attraverso vettori virali, il gene CFTR alle cellule staminali (che potrebbero essere ricavate dal midollo osseo o dal sangue del cordone ombelicale): questa tecnica è consolidata ed efficiente. Difficile la fase successiva: alcuni gruppi hanno dimostrato che, sottoposte a particolari condizioni di crescita, queste staminali possono trasformarsi in cellule dell’epitelio polmonare e che possono “migrare” e andare ad insediarsi nel polmone. Qui potrebbero dare origine a tessuto nuovo, sano e funzionante. Ma la quantità e la durata di questo “ripopolamento” cellulare è apparsa finora molto modesta. Gli esperimenti sono stati condotti finora soprattutto su modelli animali (topi) e in futuro ci saranno certamente nuovi sviluppi.
1) Griesenbach U, Alton E “Gene transfer to the lung : lessons learned from more than 2 decades of CF gene therapy” Advanced Drug Delivery Reviews 2009; 61:128-39