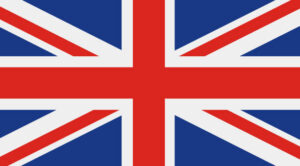Miriam Colombo è una giovane donna che ha deciso di non farsi travolgere dalla fibrosi cistica. Ha scelto una strategia tutta sua, che richiede forte dedizione e una buona dose di grinta, e che prevede di saltare dall’altra parte della barricata: da paziente a medico per provare a dominare la malattia, per tenere sotto controllo la paura con la conoscenza. Al momento è studentessa al secondo anno di Medicina, macina esami a buon ritmo e, come dice lei, non ha tempo per altro se non lo studio, le terapie e il sostegno alla ricerca.

Partiamo da un dettaglio leggero: ballo delle debuttanti di Villa Nobel a San Remo, agosto 2022. È stato come ti aspettavi?
È un ambiente di altri tempi che in fondo non mi appartiene, ma ho pensato che dovevo assolutamente andarci perché il mio fine era la ricerca: raccontare alle persone cosa vuol dire vivere con la fibrosi cistica.
Quindi è stata una serata di lavoro?
Non ho nemmeno ballato! Ma ne è valsa la pena: so che può essere difficile passare dall’atmosfera leggera di un ballo all’ascolto della mia storia, ma in tanti si sono commossi.
Cosa vuol dire la tua scelta di studiare medicina?
Parte dalla malattia. Il 2018 è l’anno in cui è iniziato il mio declino: lunghezza, frequenza dei ricoveri, complicazioni come il diabete, le polmoniti, la tbc… Da quel momento, ho sentito di voler dare al mondo della medicina tanto quanto ho sempre ricevuto, in primis dal mio stesso reparto FC del Gaslini. Ero in terza superiore e lì ho deciso: faccio Medicina.
Piuttosto di essere travolta dalla malattia stai cercando di prendere il comando. Ma in pratica funziona questo tuo metodo?
La parte difficile è cominciata nel 2018. Nel 2019 mi diagnosticano la tubercolosi. Il Natale e i miei 18 anni li passo in isolamento; dopo 40 giorni di ricovero torno a casa. Come ho preso la diagnosi? È una notizia che con una malattia di base come la FC spaventa ancora di più, ma ho razionalizzato: “siamo nel 2019, ci sono le armi per combatterla” mi sono detta. Nel 2020 il mio FEV1 tocca il fondo, dopo due mesi di ricovero mi diagnosticano l’aspergillosi broncopolmonare allergica. Inizio il cortisone, non mi riconosco più allo specchio. Mi viene il diabete, inizio l’insulina e metto un sensore fisso per la glicemia. Nello stesso ricovero, a causa dei continui farmaci endovena, vado in sala operatoria per mettere il port-a-cath. Nel 2021, iniziato con i miei vent’anni festeggiati sempre lì, per rimanere stabile devo farmi le flebo di antibiotici anche a casa e, per mangiare, inizio la nutrizione parenterale. Dei primi sei mesi del 2022, quattro li passo in ospedale: l’ultimo ricovero ne è durato tre, da marzo a giugno. Entro con quattro polmoniti, piegata in due per respirare, per il dolore al torace. Mi dicono che non ci sono più antibiotici che funzionano, tentano con uno appena arrivato. Gli effetti collaterali sono così forti che mi posso muovere solo in sedia a rotelle. Non basterebbe un libro per raccontare quante me ne siano successe ma, per rispondere alla domanda, se mi facessi schiacciare ogni volta dalla paura, non mi rialzerei più. Cerco di razionalizzare dove possibile. Mi serve qualche giorno per metabolizzare le notizie, ma poi inquadro il problema, penso “anche stavolta ho le armi per affrontarlo”. E allora vado come un treno.

Stai parlando con distacco, come stessi trattando di qualcun altro che sta male.
Vero. Provo più curiosità che angoscia. Mi dico, vediamo cosa imparo questa volta. Alla mia prima crisi di emottisi mia mamma era tanto spaventata. Io sapevo cosa stava succedendo, spesso sono io a tranquillizzare i miei. Insomma, guardo il quadro d’insieme e con distacco cosciente lo affronto.
Scelta furba ma molto razionale. Funziona sempre?
Non sono un automa: mi preoccupo ma la conoscenza mi aiuta a non cadere nel panico. È un modo per tenere sotto controllo la paura, che è deleteria, non serve. Le mie mutazioni sono rare e per ora non c’è una cura per me. Io vivo pensando che prima o poi arriverà una soluzione anche per me e non avrei scelto di studiare Medicina se non fossi certa che questo succederà. Nel frattempo, faccio cinque ore di terapie ogni giorno: i medici mi dicono che sono un soldatino ma queste sono le mie armi per arginare, per aspettare che arrivi la cura.
Hai una fiducia molto solida nelle possibilità della scienza.
La ricerca, la Fondazione sono sempre state la mia luce in fondo al tunnel, anche se cerco di non crearmi false speranze. Guarda cosa è successo con gli ultimi farmaci: persone a me care in situazioni davvero molto critiche hanno ripreso vita e in quel momento è stato come se quel farmaco l’avessi preso io. Le soluzioni arrivano quando è il loro momento, spero solo che arriveranno in tempo per me.
Una cura in tempo per Miriam. E poi, dimmi qualche altro desiderio.
Quando ci sarà la cura per me, vorrei continuare ad aiutare gli altri con il sostegno alla ricerca: vorrei essere l’esempio lampante che l’attesa vale la pena. La storia di questi ultimi vent’anni lo dimostra perché l’aspettativa di vita era disastrosa ma ora la scienza ci ha regalato una svolta. Mi piace dire che la Fondazione permette di svegliarci al mattino pensando che non sia un giorno in meno, ma un giorno in più.
Nell’attesa della cura adatta a te, che aggettivo ti descrive meglio?
Sono fiduciosa, zen al 100%. I nuovi farmaci sono un dono, svegliarsi ogni giorno è un dono. Sono anche un po’ impaziente perché vedo com’è cambiata la vita di chi li assume: mentalmente deve essere una bomba affrontare la vita senza malattia!
Chi ti aiuta in questa tua versione zen-fiduciosa?
I miei genitori sono fonti inarrestabili di energia soprattutto nel sostenere la ricerca, i miei nonni sono fiumi in piena e l’amore della mia famiglia è per me un motore fondamentale. Poi ho un rapporto privilegiato con un’amica cara che mi ha sempre aiutato nei momenti più difficili: una spalla a cui appoggiarmi, anche se a due metri di distanza. C’è anche una figura più lontana nel tempo. Avevo sei anni e il medico stava parlando ai miei genitori della mia malattia. “Ho la fibrosi cistica – gli ho chiesto – ma guarisco?” “Sì, guarisci”, mi ha risposto. Da allora quella è rimasta una promessa su cui conto.
Questa intervista compare anche sul Notiziario FFC Ricerca 61.