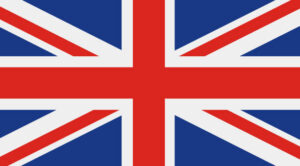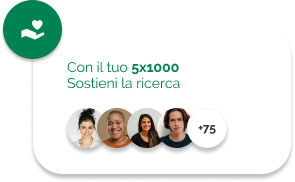Obiettivo della ricerca (1) indagare l’esistenza di una possibile associazione fra fattori sociopsicologici e andamento della malattia FC. In un’indagine precedente questi ricercatori, che lavorano presso il Centro FC di Minneapolis (Minnesota), avevano inviato a casa dei pazienti di quel centro un questionario che esplorava, in un campione di ragazzi e ragazze FC, il disagio psicologico legato alla malattia, le preoccupazioni, l’aderenza al programma di cura. Le risposte avevano suggerito come fossero le ragazze quelle che soffrivano di un peso psicologico maggiore, che si traduceva in maggior scoraggiamento, maggior difficoltà a rendere manifesta la malattia (per esempio tossendo in pubblico); oppure riuscendo in minor grado a praticare attività fisica o seguire una dieta ipercalorica (per il timore di ingrassare) o semplicemente assumere i farmaci. Gli stessi autori hanno perciò ipotizzato che ci possa essere una relazione fra alcune caratteristiche psicosociali, risultate più critiche nelle ragazze FC, e un andamento sfavorevole della malattia. E questo perchè da anni si discute se la malattia FC abbia un’evoluzione diversa nei maschi rispetto alle femmine, con un andamento complessivo meno benigno nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Alcune ricerche svolte intorno agli anni 90 avevano in effetti suggerito che i maschi fossero “privilegiati”, dato che avevano le migliori curve di sopravvivenza. Questa differenza (conosciuta con la sigla di “gender gap), negli ultimi studi si sta nettamente riducendo e le curve assumono andamenti sovrapponibili; ma qualche dubbio rimane e rimane l’interrogativo circa le ragioni, mai conosciute, che eventualmente renderebbero le donne FC, in termini di durata della vita, sfavorite rispetto ai maschi.
La ricerca di cui riferiamo è stata proposta, mediante invio a casa di un questionario, a 177 ragazzi e ragazze (di età compresa fra gli 8 e i 21 anni), assistiti presso il Centro FC di Minneapolis: hanno risposto e sono poi risultati inseribili nello studio 90 soggetti (51% del gruppo originario), 43 ragazzi e 47 ragazze, con un’età media di 14.9 anni (le femmine erano un po’ più “vecchie” : età media 15.8 rispetto a 13.9 dei maschi). Il questionario indagava varie aree della sfera psicosociale: oltre alle preoccupazioni indotte dalla malattia (per esempio il timore di apparire troppo magro/a o troppo grassa/o), la capacità di automotivazione alle cure o al contrario la tendenza allo scoraggiamento, i rapporti più o meno sereni con i genitori, le relazioni con i coetanei, il livello di autostima, i comportamenti a rischio (consumo di sigarette, vino, superalcolici), l’aderenza alla fisioterapia e così via. Il questionario è stato restituito per posta al Centro e nei diciotto mesi successivi a quel momento sono stati raccolti i dati della funzionalità respiratoria (espressa in FEV1) e dello stato nutrizionale (indicato dal rapporto peso/peso ideale per l’altezza).Ogni soggetto maschio e femmina ha potuto così disporre di una media di circa 8 controlli.
Il totale dei 90 partecipanti è stato suddiviso in tre fasce d’età (8-12; 13-17; oltre 17) e i dati clinici analizzati per fascia d’età; e poi è stata studiata l’associazione fra i dati clinici per età e le risposte al questionario psicosociale.
La cosa interessante è che, pur risultando simile fra maschi e femmine, nel periodo complessivo dei 18 mesi, la tendenza ad un certa diminuzione dei valori della FEV1, le giovani di ogni fascia d’età mostravano una più grande variabilità dei risultati della FEV1e dell’indice nutrizionale. Per entrambi i dati, FEV1 e indice nutrizionale, la variabilità era espressa attraverso un indice statistico chiamato “deviazione standard”, indice sempre maggiore nelle femmine rispetto ai maschi, in particolare significativamente maggiore nel gruppo delle ragazze di età compresa fra 13-17 anni (ciò significa che i maschi sono più simili tra loro per FEV1 e stato nutrizionale di quanto non lo siano le femmine).
Incrociando poi i dati clinici con i dati psicosociali, ne è risultato che nei maschi sembrava esserci un’associazione fra alti valori di FEV1 e alto livello di autostima e anche fra scarsa capacità di attività fisica e bassi valori di FEV1; nelle femmine la bassa FEV1 era associata a un complesso di fattori, più rappresentati che nei maschi: la preoccupazione circa la capacità di riuscire a fare attività fisica, le tensioni con i genitori, la non aderenza alle cure. Riguardo a quest’ultimo dato, le ragioni spesso descritte erano l’imbarazzo dovuto al tossire in pubblico e il senso di limitazione di fronte alle prove fisiche.
Attenzione: individuare attraverso una ricerca ben fatta (come è questa) un’associazione tra alcune caratteristiche psicosociali e i dati clinici della malattia, non vuol dire che fra le prime e i secondi vi è una relazione di causa ed effetto (cioè che una cosa è la causa dell’altra). Sono gli stessi autori della ricerca a sollevare la questione (nelle ragazze è venuto prima il peggioramento della funzionalità respiratoria e poi il senso di scoraggiamento o viceversa?). Rimane comunque aperta la questione “oggettiva” delle ragioni che possano spiegare la grande variabilità di andamento della malattia FC all’interno delle adolescenti.
1) Patterson JM, Wall M et all “Associations of psychosocial factors with health outcomes among youth with cystic fibrosis” Pediatric Pulmonology 2009 ; 44:46-53