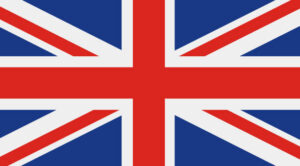Nel corso del progetto, i ricercatori hanno realizzato 18 colture cellulari ex vivo, che sono state opportunamente validate e conservate a lungo termine in condizioni controllate. Queste colture, che si aggiungono alle 24 ottenute nel corso della precedente fase del progetto sono state ottenute a partire da cellule staminali epiteliali nasali riprogrammate isolate da pazienti con fibrosi cistica (FC) con diversi genotipi (omozigoti F508del; eterozigoti composti F508del/altra mutazione; genotipi rari privi della mutazione F508del) o di soggetti eterozigoti (portatori sani) e individui sani senza alcuna mutazione del gene CFTR. A partire da queste cellule staminali, i ricercatori hanno generato e validato modelli di fibrosi cistica che riproducono il tessuto patologico in vitro (air liquid interface o ALI-cultures e organoidi nasali). Su questi modelli cellulari, il gruppo di ricerca ha così messo a punto diversi test per la caratterizzazione biochimica e funzionale del CFTR dopo trattamento farmacologico per determinare la risposta delle diverse varianti genetiche (theratyping) a modulatori già approvati come Kalydeco, Orkambi, Symkevi e Kaftrio. Dagli studi è emerso che i modelli e i test messi a punto dai ricercatori mostrano una generale bassissima attività di Kalydeco, Orkambi e Symkevi, e una marcata risposta a Kaftrio in tre genotipi con la mutazione F508del associata ad altre mutazioni, in particolare quelle che determinano lunghe inserzioni nucleotidiche.
È stata anche valutata la risposta a Kaftrio di altre varianti genetiche rare di malattia (prive della mutazione F508del): i risultati più promettenti sono stati ottenuti per la variante L1077P del gene CFTR.
Questi modelli cellulari, basati sulle cellule condizionalmente riprogrammate, si sono mostrati particolarmente preziosi per il theratyping ex vivo e potrebbero contribuire a miglioramenti terapeutici, con indubbi benefici anche per i pazienti con varianti rare di CFTR, tuttora privi di terapie mirate approvate.